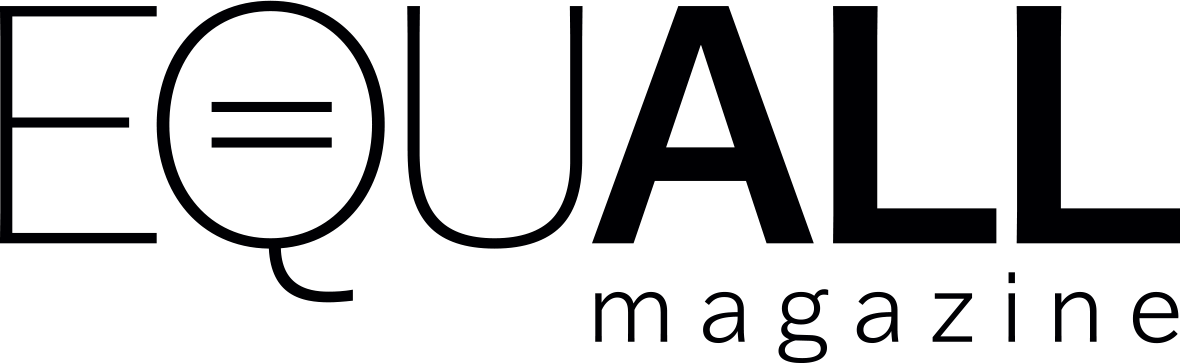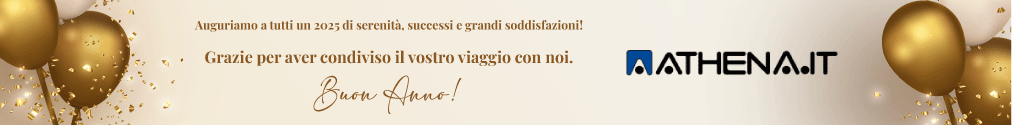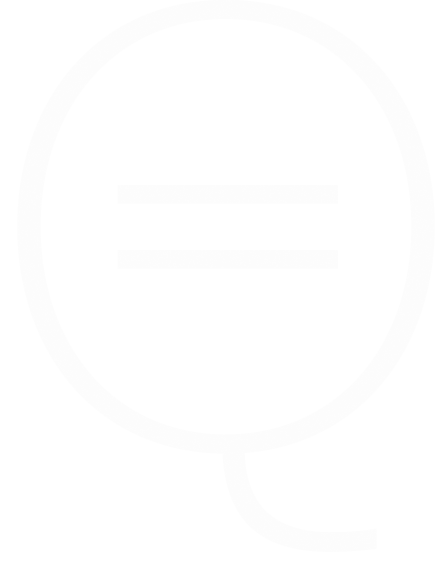AGI – È una delle fotografie-simbolo della seconda guerra mondiale, ma in realtà in quel 23 febbraio 1945 sul monte Suribachi, sull’isola di Iwo Jima, di pose ne vennero scattate due, a distanza di pochi minuti l’una dall’altra. La prima fu presa da Louis R. Lowery, la seconda da Joe Rosenthal: nota come Raising the Flag on Iwo Jima e diffusa dall’Associated Press, avrebbe fatto il giro del mondo, riprodotta sui libri e non solo, e premiata nel 1945 con il Pulitzer.
L’isola difesa a oltranza dai giapponesi e un bagno di sangue in un ambiente ostile
L’isola vulcanica di Iwo Jima, nell’arcipelago delle Marianne, era stata attaccata dalle truppe statunitensi il 19 febbraio. Appena 20 chilometri quadrati, arida, aria che teneva fede al nome (isola dello zolfo), ma posizione strategica, poiché metteva il Giappone nel raggio d’azione dei bombardieri americani con il supporto dei caccia di scorta. I B-29 avevano circa 6.000 km di autonomia, ma i Mustang si fermavano a 1.500, e senza di essi le Superfortezze volanti sarebbero state contrastate efficacemente dagli Zero. Il comando nipponico aveva perciò dato ordine di resistere fino all’ultimo uomo; la marina imperiale, fatta a pezzi alla fine di ottobre del 1944 nella battaglia di Leyte, non aveva più alcuna possibilità di sbarrare il passo agli americani sul mare. Gli strateghi statunitensi avevano adottato il cosiddetto “salto della rana” per le isole del Pacifico, al posto di continui e sistematici sbarchi. Iwo Jima non poteva in alcun modo essere superata: c’erano campi d’aviazione realizzati dai giapponesi e pure un impianto radar che dava l’allarme alla madrepatria. Il generale Tadamichi Kuribayashi poteva fare affidamento su 21.000 soldati determinati a battersi fino all’ultimo in un ambiente ostile ma a essi ben noto, preparato a dovere con tunnel collegati, bunker, trappole esplosive, postazioni nascoste e assenza di zone morte su cui dirigere il tiro. Tanta determinazione era stata all’inizio sottovalutata nell’Operazione Detachment condotta dal generale Holland Smith, che prevedeva al massimo dieci giorni di combattimenti, aperti da un terrificante bombardamento navale, come mai avvenuto prima d’allora. Poi ondate di sbarchi, con oltre70.000 uomini risucchiati all’interno da una sanguinosissima tattica di stillicidio. Anche se l’esito era scontato, una delle battaglie decisive della seconda guerra mondiale si concluderà solo il 25 marzo, con il totale annientamento delle forze giapponesi e la vittoria americana, costata però quasi 25.000 morti. Mai prima di allora le perdite statunitensi erano state superiori a quelli nipponiche, e mai lo saranno dopo. Quanto accaduto sull’isola, e il timore che potesse ripetersi, rimosse uno dei rimanenti freni al lancio della bomba atomica.
Urla di gioia dei soldati e le sirene delle navi per salutare stelle e strisce al vento
Che il monte Suribachi, che si ergeva a 168 metri sul livello del mare, fosse uno dei nodi della battaglia, era chiaro sin dall’inizio, e su di esso si concentrarono gli sforzi dei primi giorni, fino appunto al 23 febbraio, quando giunsero in vetta alcuni marines del 28° reggimento della 5ª divisione, dopo una serie di scontri di logoramento per spezzare la continuità delle linee giapponesi. L’attacco risolutivo, preparato dal bombardamento navale e aereo, fu condotto dopo una ricognizione da parte di due pattuglie del 2° battaglione del tenente colonnello Chandler Johnson che ordinò l’avanzata a una quarantina di soldati del tenente Harold G. Schrier e pure di piantare sulla cima la bandiera a stelle e strisce della nave da trasporto Missoula. Materialmente la bandiera, posizionata su un tubo metallico, venne issata dopo aver soffocato un’ultima resistenza, attorno alle 10.20, dal tenente Schrier e dal sergente Henry Oliver Hansen. La scena non era passata inosservata al sergente Louis R. Lowery, fotografo della rivista del Corpo dei marines, che fissò il momento su pellicola, mentre sulla spiaggia i soldati prorompevano in grida di gioia e al largo le navi azionavano le sirene. Quella bandiera venne poi richiesta dal Segretario della marina da guerra Vincent Forrestal, ma Jonhson fece in modo di sostituirla con un’altra proveniente da un’altra nave da sbarco che venne quindi portata sul Suribachi da alcuni marines. La stessa strada la percorrevano il fotografo della Associated Press Joe Rosenthal e il corrispondente di guerra Bill Hippie, il fotografo Bob Campbell e il cineoperatore Bill Genaust che avevano appreso al comando di battaglione della missione di sostituzione della bandiera da parte del sergente Michael Strank. Rosenthal scattò la sua foto nonostante sulla strada avesse appreso che il momento originale fosse stato già fissato da Lowery. Nello scatto compaiono sei uomini – cinque marines e un assistente di sanità – che alzano la bandiera. La scena era stata ripresa da Genaust, mentre poi Rosenthal e Campbell avevano scattato altre fotografie dei marines che esultavano nel vedere la bandiera garrire in cima al monte.
Un’icona assoluta della seconda guerra mondiale
Raising the Flag on Iwo Jima era da subito a destinata a diventare un’immagine iconica, anche se Rosenthal apprenderà dello straordinario successo solo nove giorni dopo averla fatta arrivare all’Associated Press che l’aveva pubblicata dopo una manciata di ore da quando era stata scattata. Popolarissima, riprodotta dappertutto, su poster, cartoline e francobolli, divenne immediatamente uno straordinario elemento di propaganda e per alimentare la campagna di sottoscrizione dei buoni del tesoro a sostegno dello sforzo bellico. Si cercarono immediatamente i sei soldati immortalati nell’atto di innalzare la bandiera, ma alla battaglia erano sopravvissuti solo i caporali dei marines Harold Keller e Ira Hayes, e l’assistente di sanità John Bradley, mentre erano caduti Harlon Block, Franklin Sousley e Michael Strank. Per di più Block sarà confuso fino al 1947 con Hank Hansen, Bradley con Harold Schulz e Keller con René Gagnon fino al 2019.
Dal monumento al Museo dei marines al film capolavoro di Eastwood
La fotografia diventerà monumento in bronzo a grandezza naturale nel 1954. Hayes, Bradley e Gagnon poseranno per lo scultore Felix De Weldon, mentre i volti dei tre compagni saranno ricostruiti attraverso le immagini fotografiche. Ambedue le bandiere issate sul Suribachi sono conservate nel National Museum of the Marine Corps di Quantico. Quasi del tutto dimenticata, invece, la prima foto di Lowery. La vicenda è stata al centro nel 2006 del film Flags of our Fathers, metà dello straordinario dittico cinematografico che il regista Clint Eastwood ha dedicato alla battaglia di Iwo Jima raccontata dalla prospettiva americana e da quella giapponese.