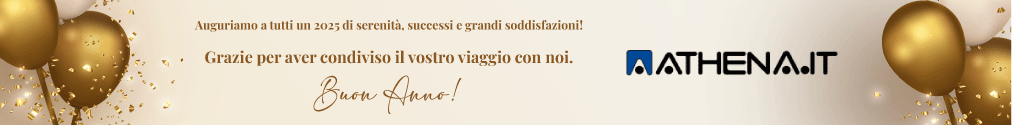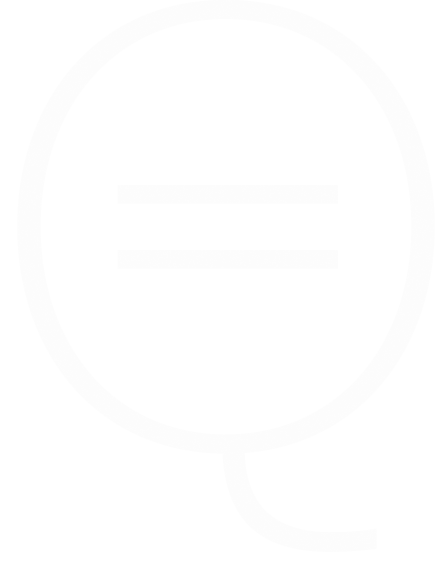Due storie che hanno fatto molto discutere negli ultimi tempi e che rappresentano il segno di un profondo rinnovamento in un mondo apparentemente chiuso e “maschile” come quello del rugby
Il rugby è considerato insieme al calcio la roccaforte di una mascolinità assoluta, tribale, tossica e senza indecisioni. Eppure, uno sguardo più approfondito all’interno ci aiuta a capire che sotto questa crosta apparentemente inviolabile di pregiudizi e dogmi, molto si sta muovendo.
E così il rugby si regala due storie di segno opposto, che mostrano i lati della medaglia in tutta la loro umana crudezza. La prima è quella dell’atleta queer Jade Konke Roberts, 29 anni, esempio vivente di come sia sbagliato lo stereotipo secondo cui lo sport non è un luogo accogliente per le persone LGBTQ+.
Jade è una giocatrice professionista di rugby con la squadra femminile degli Harlequins (Scozia), cresciuta in una famiglia dove tutti erano appassionati della palla ovale.
All’età di nove anni, gioca un anno in una mini-lega in una squadra mista, poiché non c’è una squadra femminile e non è prevista la sua creazione; e così dopo poco decide di smettere, ma dopo qualche tempo riprende a giocare fino ad arrivare a 17 anni ad essere convocata nella Nazionale scozzese under 20 femminile.

In quel periodo si trasferisce a Glasgow, una grande città dove può esplorare la sua identità e la sua sessualità in modo più completo per la prima volta. A differenza di quanto si possa pensare, il suo coming out viene non solo ben accolto dalle compagne di squadra, ma viene anche protetta ed incoraggiata ed essere se stessa e non nascondersi.
“Quando avevo 18 anni e mi sono trasferita a Glasgow credevo che non avrei mai potuto uscire allo scoperto ed essere me stessa perché la gente pensa che in una squadra di rugby sia normale così. Invece, nessuno ha fatto una piega e mi sono trovata in un ambiente veramente accogliente e favorevole per esprimermi”.
Jade è profondamente consapevole che le cose non sono così semplici in altri posti. Mentre il rugby femminile le ha fornito uno spazio confortevole per abbracciare la sua sessualità, ma altri non sono così fortunati.
E la dimostrazione di questa realtà arriva dall’altra storia che ha tenuto banco nell’ultimo mese, quella di Israel Folau, 34 anni, giocatore australiano di origini tongane, attualmente in forza agli NTT Shining Arcs nella massima serie giapponese.

Folau non ha mai fatto mistero delle sue convinzioni religiose. È un fervente cristiano evangelico che in passato non ha perso occasione per esternar e sui social il suo odio nei confronti dei gay scrivendo che “l’inferno aspetta ubriaconi, omosessuali, ladri, fornicatori, adulteri, atei e idolatri”, invitando tale categorie a “pentirsi e a convertirsi a Gesù Cristo”.
Queste esternazioni nel 2019 gli sono costate il posto nella Nazionale australiana e la rescissione del contratto con la Federazione Australiana di Rugby, motivo per il quale è andato prima a giocare in Spagna nei Draghi Catalani e dopo in Giappone.
Il suo nome è tornato alla rubala a fine maggio, quando il CT Steve Hansen, ex allenatore degli All Blacks neozelandesi, l’ha convocato per l’incontro benefico Barbarians-World XV, un’esibizione tra i migliori giocatori del mondo. Una convocazione che ovviamente ha scatenato un vespaio di polemiche che Hansen si è scrollato di dosso dichiarando semplicemente: “L’ho chiamato perché è un grande giocatore. Sapevo che la sua convocazione avrebbe provocato delle polemiche e ferito alcune persone, ma a me interessa il giocatore e non le sue idee, che peraltro non condivido”.
Ma il vero contrappasso per Folau è stato vedere esposto un vessillo arcobaleno in segno di solidarietà verso la comunità LGBTQ+ allo stadio prima della partita, poiché questo era il grande tema dell’evento. E così, suo malgrado, anche lui ha potuto vedere con i suoi occhi i segni dei tempi che cambiano. Che lui lo voglia o meno.